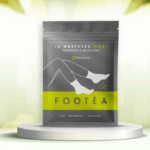L’alcol è riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale come un agente cancerogeno per l’essere umano. Questa affermazione, sostenuta dall’International Agency for Research on Cancer e dal World Cancer Research Fund, implica che ogni tipo di bevanda alcolica – vino, birra o superalcolici – contribuisce ad aumentare il rischio di sviluppare tumori maligni. Non esiste una soglia di consumo sicura: anche quantità modeste di alcol, se assunte regolarmente, comportano un pericolo concreto per la salute. La correlazione tra consumo di alcol e insorgenza di tumori è stata documentata in modo esaustivo negli ultimi decenni, mettendo fine a molti fraintendimenti diffusi nell’opinione pubblica.
Classificazione dell’alcol come cancerogeno
Sin dal 1988, l’alcol è stato inserito tra i cancerogeni del gruppo 1 dall’International Agency for Research on Cancer (IARC): ciò vuol dire che esiste una solida evidenza scientifica a supporto della sua responsabilità nell’aumentare l’incidenza di diverse forme di tumore tra cui quelli della bocca, faringe, laringe, esofago, colon-retto, fegato e seno. La tossicità dell’alcol non risiede soltanto nella quantità consumata, ma anche nella regolarità e nella durata nel tempo del consumo stesso. L’effetto cancerogeno è una conseguenza diretta dei processi metabolici molecolari che l’alcol induce nell’organismo: una volta assunto viene convertito in acetaldeide, una molecola anch’essa cancerogena, capace di danneggiare permanentemente il DNA delle cellule.
Un aspetto molto discusso riguarda il convincimento, purtroppo radicato in alcune culture, che consumare modeste quantità di determinate bevande alcoliche – come il vino rosso – sia addirittura benefico. La realtà epidemiologica dimostra invece che anche abitudini “moderate” accrescono sensibilmente il rischio di eventi oncologici: il rischio è proporzionale sia alla dose che alla durata del consumo, ma nessuna soglia minima è priva di pericoli.
L’inesistenza di una soglia sicura
Le attuali evidenze scientifiche affermano che non è possibile stabilire una dose di alcol completamente sicura, neanche per il cancro. Ricerche pubblicate su riviste di medicina di spicco, incluse “Lancet Public Health” e il “Journal of American Medical Association”, dimostrano che il rischio di cancro inizia ad aumentare già con il consumo leggero o moderato. Secondo le statistiche americane, circa il 30% delle morti per tumori associati all’alcol coinvolgono persone che consumavano meno di 20 grammi di alcol al giorno – quantità pari a un singolo bicchiere di vino, una birra da 330 ml o un piccolo bicchiere di superalcolico. Questo dettaglio smentisce l’idea che solo chi fa uso pesante di alcol sia a rischio.
Il concetto di “soglia sicura” suggeriva che bastasse non eccedere per evitare rischi; oggi sappiamo che la carcinogenicità dell’alcol è priva di soglia: la sola presenza della sostanza nell’organismo, anche a dosi minime, può contribuire all’insorgenza di neoplasie. Di fronte a questi dati, le principali organizzazioni sanitarie internazionali consigliano che il modo migliore per prevenire i tumori alcol-correlati sia limitare quanto più possibile il consumo di alcol. Chi non beve alcolici per ragioni di salute produce già una importante azione preventiva per se stesso.
Tumori associati al consumo di alcol
Sette sono i tipi di tumore per i quali è stata accertata una chiara associazione con il consumo di alcol:
- Tumori della cavità orale (bocca, lingua, gengive, palato)
- Tumori della faringe e laringe
- Tumore dell’esofago
- Tumore del colon-retto
- Tumore del fegato
- Tumore della mammella nelle donne
Il meccanismo attraverso cui l’alcol esercita la sua azione cancerogena è vario: comprende sia il danno diretto al DNA promosso dall’acetaldeide, sia una maggiore infiammazione cronica nei tessuti, alterazioni ormonali (con particolare impatto sul rischio di tumore al seno nelle donne), e la facilitazione dell’assorbimento di altre sostanze tossiche, come quelle presenti nel fumo di tabacco. Il rischio, infatti, è sinergico: chi beve e fuma contemporaneamente incorre in un pericolo esponenzialmente superiore rispetto a chi usa una sola delle due sostanze.
I rischi anche per “pochi bicchieri” e l’impatto sociale
L’idea che “un bicchiere al giorno non può fare male” è profondamente smentita dalle ricerche epidemiologiche. Persino un consumo moderato e saltuario è associato a un incremento di rischio per alcune patologie oncologiche e in particolare per il cancro alla mammella nelle donne, dove anche un solo bicchiere al giorno può aumentare il rischio in modo statisticamente significativo. L’impatto sulla salute pubblica è rilevante: una fetta sostanziale delle diagnosi e delle morti per cancro attribuibili all’alcol si registra tra consumatori moderati o “occasionali”, e il danno complessivo supera quello di altri tumori ampiamente pubblicizzati come il melanoma o quello ovarico.
La questione non riguarda solo l’oncologia ma tocca anche la sfera socio-culturale. Le abitudini di consumo possono essere influenzate da pubblicità, tradizioni e miti riguardo agli effetti benefici di alcune bevande alcoliche; questi ultimi sono stati smontati dalla letteratura scientifica. Sensibilizzare la popolazione sul vero peso dell’alcol nei tumori è quindi fondamentale sia per una prevenzione efficace sia per promuovere politiche pubbliche coerenti.
L’alcol inoltre causa altre patologie gravi, tra cui epatopatie croniche, disturbi neuropsichiatrici, incidenti stradali e domestici, e un aggravio significativo sui costi sanitari nazionali.
La raccomandazione finale di OMS, IARC e delle principali società scientifiche è di limitare drasticamente il consumo di alcol. Quando si parla di rischio oncologico, la posizione è netta: meno è meglio, e l’obiettivo ideale resta zero consumo per la porzione di popolazione che può scegliere di astenersi.